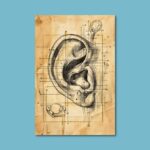
Auricoloterapia olistica: il benessere a portata d’orecchio
28/02/2025
Perfezionare l’attenzione per arrivare alla Centratura
01/04/2025A cosa serve e come praticare il perdono

Il perdono sta diventando un termine ricorrente nel linguaggio collettivo e un tema che assume sempre maggiore importanza come elemento fondante dell’essere umano che conosce e lavora su se stesso, e senza il quale la società civile non si definisce più tale.
Significato ed etimologia del termine perdono
Perdonare significa rinunciare alla vendetta, sospendere il rancore, non esigere un risarcimento extra-legge per torti, abusi, perdite, sofferenze subite. La parola perdono deriva dal verbo perdonare che equivale a condonare con “per” anziché “cum” come prefisso rafforzativo. Il latino perdonare è composto da: per —> particella intensiva o indicante compimento + donare —> concedere, donare, rilasciare, quindi per estensione di significato —> assolvere.
Il termine perdono ai tempi dei latini non aveva implicazioni religiose, perciò la sua etimologia ci riporta a un ambito laico.
Con l’arrivo del Cristianesimo questa parola viene assorbita dal linguaggio del clero e viene ad assumere il significato specifico dell’assoluzione dalle colpe che Dio concede quando il fedele riconosce, confessa e rinnega il suo peccato. Il Cristianesimo attribuisce alla parola perdono di un profondo valore etico-morale.
Questa visione fa perdere alla parola perdono il suo significato individuale per farla sottostare a regole collettive. Se si guarda alla società in cui viviamo il perdono viene sbandierato come un tratto nobilitante dell’essere umano e spesso ci si ammanta di esso come di una “medaglia al valore”.
Tu come usi la parola perdono?
Secondo me nell’usare la parola occorre prestare molta attenzione, per riconoscere con quale significato la stiamo citando.
Non perché ci sia un modo giusto e uno sbagliato, ma per accorgerci di come stiamo usando un vocabolo tanto importante e dalle sfumature tanto differenti. Mi piace pensare a questa consapevolezza come alla possibilità di dar corpo all’espressione “conosci te stesso”, tanto da trasformarla in RI-conosci te stesso.
Osservati, e grazie all’osservatore esterno – ossia quella parte di te che ti sta osservando senza giudicarti – nota come la tua macchina umana mangia, si muove, dorme, ride, si emoziona, parla e si parla. Così potrai sapere con quale accezione stai usando la parola perdono. Comprendere questo è importante perché solo se corrisponde a ciò che vuoi esprimere e a ciò che stai provando c’è reale libertà; se invece ti accorgi di essere nella trappola di un modo che senti non appartenerti e che deriva dalla società in cui vivi, questa consapevolezza ti consente di scegliere di cambiare.
L’intima essenza del perdono
Igor Sibaldi ha scritto una definizione di perdono che mi pare molto ben espressa:
“Perdonare significa riuscire a separare un individuo dalle azioni dannose che ha commesso verso altri, in modo che queste ultime non determinino l’immagine che si ha di lui o di lei.”
La parola perdono – nell’accezione di cui sopra – esonera il perdonato e il perdonante da qualsiasi implicazione etico-morale. Ed emerge chiaramente che il perdono non è un rito collettivo, ma un’azione personale. Nessuno si erge a buono illuminato che emenda il perdonato dalla sua colpa o, più fittiziamente ancora, dal suo senso di colpa. Perché il senso di colpa non è un’investitura ricevuta da fuori, ma una sensazione interna all’individuo che si manifesta in relazione al mondo esterno. Ecco perché ognuno può integrarlo nel suo bagaglio emozionale e non buttarlo via, né tanto meno farselo togliere dall’esterno.
Né si entra in un rito collettivo di purificazione, dove ciascuno perderebbe il proprio valore di individuo, che sia attore o ricevente, del perdono.
Né si scomoda un altro termine che a oggi comunemente accompagna la descrizione del concetto di perdono ossia l’accettazione.
Perdonare non include necessariamente né l’accettazione del torto subito, né l’accettazione della persona che ha commesso il fatto. L’accettazione, se non è sostenuta davvero dalla voglia e dall’intima esigenza, si chiama rassegnazione e nulla ha a che vedere col perdono. Pare quasi un invito a farsi andare bene così com’è sia il fatto da perdonare che la persona da perdonare. Una sorta di superficiale invito al concetto di “pensa positivo”, come dare una mano di bianco su un muro con la muffa. È evidente che non sarà sufficiente.
Sia il perdono che l’accettazione non ammantano di nobiltà chi li mette in pratica, non rendono migliori (rispetto a chi? a che cosa? perché?), non necessitano di altoparlanti, ma rispondono a un’esigenza interiore. Si può accettare qualcosa o perdonare qualcuno soltanto quando il dolore provato avrà smesso di fare male, soltanto quando potrà diventare strumento per altro.
Il perdono come possibilità di ampliare la propria visione
Il perdono certamente non cambia l’evento accaduto, ma permette che esso possa diventare la scintilla per accorgersi di altro, come se si fosse acceso un fascio di luce inatteso.
Posto che nella nostra società il grasso è malvisto, è brutto, ed è sinonimo di scarsa cura, facciamo un esempio: se ti offendi e/o sei ferita/o perché ti appellano “ciccione/a” non è il grasso a ferirti, ma lo spot di luce sulla poca cura di te resa manifesta dal grasso.
Che cosa accade guardando più a fondo? Emerge un non detto, ossia un vincolo, un patto sottoscritto con la società in cui si vive. E ciò emerge sia che ne siamo consapevoli – e allora ce ne accorgiamo e se non ci interessa possiamo spostarci a lato – sia che ne siamo inconsapevoli, e allora ne rimaniamo invischiati. Accorgersi di questo meccanismo è importantissimo. Infatti nel caso dell’esempio il non detto della nostra società che emerge è “quella persona ha una cattiva alimentazione, non pratica sport e non è sana”. Ciò che ti offende e/o ferisce non è tanto l’idea del grasso in sè ma aver mancato l’adeguamento al rito collettivo della cura di sé, e ti offenderà molto se ci credi, pochissimo o per nulla se non ci credi.
Se qualcuno mi ferisce e separo l’individuo dall’azione che ha commesso – come indica la definizione di perdono citata precedentemente – posso accorgermi che esistono due realtà differenti: la persona che agisce ed il suo agito. Questa differenziazione apre due possibilità importantissime:
- Posso scegliere di indagare su ciò che mi ha ferito, a prescindere da chi l’ha fatto. Ossia aprire quel portoncino che mi indicherà una nuova strada e magari mi aiuterà a lasciar andare – per citare l’esempio di prima – la modalità che mi fa mettere su grasso.
- Posso scegliere quanto e che cosa cambiare del mio rapporto interpersonale con chi mi ha ferito, senza identificare la persona con l’accaduto e magari decidere di offrirle la possibilità di mostrarmi ancora delle parti di sè, il tutto senza dover necessariamente dimenticare l’accaduto.
Separare la persona dall’agito è una conquista di libertà e assume un valore incommensurabile se ci si trova di fronte a un’azione grave o addirittura un crimine. Ciò permette infatti di volere che sia punito il crimine senza criminalizzare la persona che l’ha commesso. Si può scegliere di perdonare la persona pur volendo che venga punita come esecutore/trice del crimine. Questa possibilità permette di rispettare i propri tempi di elaborazione dell’accaduto, senza necessariamente dover avvicinare o stringere rapporti con chi ha commesso l’azione. Vissuto così il perdono restituisce libertà d’azione e di pensiero al perdonante, perché permette di evitare il “buonismo” e non lo obbliga né lo condanna necessariamente ad avvicinare chi ha agito il torto.
Posso perdonare l’esterno se non perdono prima l’interno?
Se ripenso alle occasioni della mia vita in cui ho chiamato in causa la parola perdono e ho perdonato qualcuno (o l'”assolto”, per dirlo alla latina), non ho potuto non accorgermi che anch’io ero coinvolta come attrice di quella scena della mia vita. È possibile perdonare qualcuno al di fuori senza accorgerci che siamo i creatori della nostra realtà? Se faccio appello alla mia frase mantra “Non vediamo le cose come sono, le vediamo come siamo” come posso pensare di essere soltanto vittima e non in parte carnefice? Queste considerazioni mi hanno portato a un ulteriore pensiero a riguardo del perdono.
Non posso perdonare davvero qualcuno per un torto subito, se non perdono per prima me stessa per essermi trovata proprio lì in quell’occasione.
Posso portare esempi differenti e con intensità dissimili, ma volutamente resto in una casistica media e vi racconto di quando mi hanno rubato la bicicletta.
Ho perdonato il ladro? L’ho fatto soltanto dopo aver assolto me stessa. Perché avevo legato male la bicicletta. Io ero preoccupata che mi potessero rubare la bicicletta perché era nuova e luccicante, e aveva un’immagine accattivante – pur non essendo un oggetto di grande valore. E nel mio elucubrare modi per proteggerla dai furti, recatami comunque in bicicletta in una zona dove questi avvenivano in abbondanza, l’ho legata ad un palo a cui avevano tolto la segnaletica. Rubarla è stato quindi un gioco da ragazzi, e mi sono dovuta assolvere dalla mia parte di complicità prima di poter perdonare il responsabile esterno.
Siamo i complici di ciò che viviamo, che è semplicemente un modo differente di dire che siamo gli artefici, i creatori del nostro vivere, della nostra realtà.
Se accettiamo questo assunto, e talvolta facciamo corsi per imparare a creare la nostra realtà in positivo, possiamo smettere di pensare che per le cose negative invece siamo del tutto non responsabili. Se siamo gli artefici del nostro vivere lo siamo sia in positivo che in negativo.
Ecco che potremmo chiederci “chi vorrei perdonare e non ci riesco?” Trovata la persona e quindi l’episodio rivolgiamoci dall’esterno all’interno e guardandoci dentro andiamo a scoprire perché non perdoniamo a noi stessi la parte che abbiamo avuto in ciò che è successo.
Vuoi approfondire questo tema e lavorarci su?
Posso darti un supporto!
Foto di Dmitri Leiciu da PxHere
