
Riflessologia, Counseling, Fiori di Bach: il simbolo nel corpo
01/07/2019
Che cosa mi ha insegnato il counseling?
08/08/2019Clara
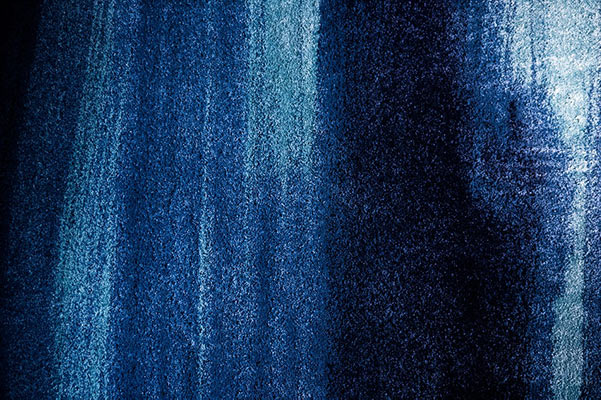
Quando sentivamo la sirena trattenevamo tutti il respiro per qualche secondo. Papà cercava lo sguardo della mamma, lei si apriva in un mezzo sorriso poi si chinava su mio fratello, lo avvolgeva in una vecchia coperta verde e se lo portava al petto. Insieme mi si avvicinavano, mi abbracciavano e mi stringevano forte. Noi lo sapevamo prima quando sarebbe suonata la sirena. Lo zio Mario dagli uffici del comune tutti i giorni ci mandava due sigarette avvolte nella carta da pacchi. Blu se il giorno dopo sembrava tranquillo. Rossa se invece il giorno dopo si prevedeva un bombardamento.
Per me la guerra non era cattiva, ero io che andavo a recuperare l’involucro, avevo imparato a custodire un segreto.
Il fischio della sirena sembrava crescere a dismisura. Tutti si zittivano. Si diffondeva un silenzio quasi irreale, di sospensione, poi le grida della paura. Il riversarsi rumoroso della folla urlante sembrava il precipitare in caduta libera di quel suono incapace di aprire la porta del cielo.
Mio fratello iniziava a piangere solo quando il caldo del rifugio diventava insopportabile. C’era puzza di sudore. Quell’odore nauseabondo prendeva alla gola,saliva nel naso, impregnava i vestiti. Qualcuno si urinava addosso. A me veniva voglia di vomitare. Allora papà mi porgeva il suo fazzoletto che sapeva di menta. Lo faceva sempre. Mentre me lo passava mi diceva “ le faccio un regalo signorina”. Io respiravo profondamente e mi sembrava di essere nel salotto buono della nonna.
Quando si accorgevano che non sarei stata male le donne del mio palazzo mi chiamavano perché pregassi con loro. Iniziavano a sgranare il rosario non appena la botola si chiudeva sopra di noi. Quella nenia irritava papà che si spazientiva ed incominciava a parlar male dei fascisti. Li chiamava “i provinciali”, poi alzava la voce e continuava “bisogna essere grandi anche nel male allora per meritare l’inferno, a loro non spetta neanche quello, poveretti”. La mamma staccava mio fratello dal suo seno e con un pretesto qualsiasi chiamava dolcemente suo marito. Lui allungava le braccia per accogliere mio fratello ed iniziava a cantagli le canzoncine. La portinaia sorrideva complice alla mamma. Le donne sapevano come distrarre i loro uomini spaventati quanto loro, ma impossibilitati a difenderle come avrebbero voluto.
Per me la guerra non era cattiva. Ne riconoscevo i ritmi, i suoni, gli odori.
Il Signor Vergnano tirava fuori le carte ed iniziava a mischiarle. Pian piano si facevano attorno a lui un folto gruppetto di uomini. Dapprima parlavano del calcio, del tempo, di quando si andava in bicicletta fuori porta a comprare la verdura e le gambe erano forti e robuste. Poi il marito della portinaia tossiva e faceva cadere una carta. Chi la raccoglieva avrebbe fatto coppia con lui, gli altri due si avvicinavano senza dire una parola. Ecco costituito il solito quartetto. Tutte le donne li guardavano male. Uomini senza Dio era il loro soprannome. A me piacevano. Dalle loro tasche usciva sempre qualche caramella. Loro si ricordavano sia il mio nome che la mia età. Quando mi incontravano per le scale mi chiedevano di raccontare che cosa avevo imparato a scuola. Il signor Gino, vendeva le uova al mercato, si alzava sempre all’alba, ed era un mio amico. Una volta noi del quartiere centro eravamo stati buttati dentro il rifugio dalla polizia, e lui aveva dovuto lasciare le galline nelle gabbie al mercato. Era preoccupato di non trovarle più al ritorno. Si agitava e muoveva le braccia su e giù come ali. Tutti lo avevano preso un po’ in giro e talvolta si levava ancora una voce che imitava lo starnazzare di una gallina. Gino mi aveva chiesto in segreto di insegnargli a scrivere il suo nome e quello degli altri che giocavano a carte con lui. Così ogni volta che si ritrovavano poteva sbuffare e lamentarsi della pigrizia dei suoi compagni di gioco che non volevano scrivere. Prendeva la matita e segnava i nomi delle coppie per la partita a scopone. Io mi avvicinavo piano e guardavo se avesse scritto tutti i nomi giusti. Quello difficile da imparare per lui era stato Guglielmo, non si ricordava se mettere o no la g prima della elle, allora si fermava, rifletteva, e posava la mina sul mento lasciando un circolino nero. Quando mi vedeva sorridere allora mi passava la mano ruvida e tremante fra i capelli. Era il nostro segnale che andava tutto bene. Tra gli uomini senza Dio c’era anche il farmacista. Lui era sempre serio. Quando salutava alzava solo il mento stirando le labbra. Parlava con la mamma e le chiedeva con voce seria il peso di Federico. A me non diceva mai nulla se ci incrociavamo per la strada, ma quando ci incontravamo nel rifugio si trasformava in mago. Dalle sue mani, misteriosamente, uscivano monete, fazzoletti colorati, ostie, e poi una caramella alle erbe alpine. Mentre scartavo quel regalo lui si raccomandava di mangiarla a fine pasto, facendo sempre attenzione di esaurire le raccomandazioni, quando della caramella non c’era più traccia. Poi si voltava verso papà e scusava per la confidenza. A me faceva ridere, Il babbo lo ringraziava e gli sorrideva con gentilezza. Lo guardava con deferenza. Quando eravamo a tavola parlava di lui chiamandolo “un signore d’altri tempi, uno speziale, mica le scatolette già pronte”. Quindi si rivolgeva alla mamma e le diceva con tono serio “Emma bisogna andare sempre da lui. Ti ricordi quando mi ha tolto la scheggia dal braccio? Che mano ferma, non ho sentito il minimo dolore!”. La mamma gli sorrideva e gli ricordava che le lamentele per il male insopportabile le aveva riservate tutte a lei durante la notte. Ma lui già stava decantando la bontà della cucina della sua bella moglie. Papà non chiedeva mai scusa, improvvisamente si ricordava quanto fosse abile la moglie e perfetta la figlia. Così noi passavamo sopra alle sue bizze e ci facevamo complici delle sue scappatoie. La mamma sorrideva con lui anche quando era arrabbiata, perché pensava che “ai bimbi troppo cresciuti come gli uomini” servivano poche regole e tanta fiducia. Non capivo bene ciò che intendesse, ma l’ascoltavo con attenzione. Volevo essere come lei sempre tranquilla, serena, con lo sguardo limpido di chi va per la sua strada in compagnia delle persone che ama.
Per me la guerra non era cattiva, osservavo, ascoltavo, imparavo e mi facevo degli amici.
Dopo un po’ qualcuno si radunava attorno al colonnello. Lui era il più bravo a raccontare le storie. Ascoltavamo rapiti resoconti su battaglie, amori clandestini, ritrovamenti di fratelli dispersi, fantasmi, animali parlanti…. Pensavamo tutti che fossero delle invenzioni, soltanto il colonnello credeva davvero a ciò che raccontava Poi la botola si apriva. Tutti correvano alle loro case. Nessuno diceva più niente. Facevamo finta che il tempo non si fosse fermato. La nonna, che veniva a farci visita il giorno dopo, ancora sulla porta di casa si scusava per non essere potuta venire a trovarci prima per il “disguido”.
Ma a metà della storia della “bella contessa dai capelli rossi…”, sentimmo un colpo sordo fuori dalla cantina. Si aprì la botola. I Tedeschi erano entrati col fucile già in mano. Nessuno fiatava. Fui separata dai miei genitori. Le donne vennero portate nella stanza accanto. Qualcuna di loro urlava. Gli uomini, con le mani sopra la testa, in fila indiana salirono le scale. Noi bambini ci sedemmo con la faccia contro il muro. I peli delle braccia mi si rizzarono. Ricordo bene quella sensazione. Poi gli spari. Le donne smisero di urlare. Piangevamo tutti. In silenzio con gli occhi chiusi, cullandoci l’un l’altro. Un soldato mi diede un colpo sulla spalla e mi chiese di prendere mio fratello in braccio, veniva dall’altra stanza, l’aveva staccato dalla mamma. Federico dormiva. Lui era l’unico a non piangere. Io tremavo. Lui no. Il soldato mi fece alzare per prendere la coperta. Mentre gli passai al fianco mi chiese quanti anni avessi. Non risposi. Lo guardai fissamente. L’unica cosa che mi venne in mente fu troppi. Improvvisamente mi sentivo pesante. Comprendevo il tortuoso cammino della serenità, lo sforzo di vivere normalmente anche se nulla ti consentirebbe di farlo. Avevo ricevuto quel dono per tanti anni, ora lo cedevo a Federico. Solamente lui ora poteva accettarlo. Io ero già troppo grande. Poi i Tedeschi se ne andarono. La mamma varcò la soglia e mi cercò con lo sguardo. I suoi occhi erano lucidi, ma lei non piangeva. Con la mano si massaggiava il collo. Le avevano strappato la collana della nonna. Circondò col suo corpo tremante sia me che Federico. Non le chiesi niente. Salimmo le scale vicine vicine. Il suo buon odore mi conduceva come un filo invisibile. La luce fioca del pomeriggio sembrava intensissima. Esitai sull’ultimo gradino. La sua mano calda e morbida scivolò inesorabilmente sui miei occhi. Buio. Abbassai le palpebre. Avevo la bocca secca. Quel calore mi anestetizzava la vista, l’olfatto, l’udito, i pensieri. Appoggiai la fronte a quella mano. Poi decisi. Spalancai gli occhi. La mano si ritrasse. Andammo a casa. Sono tornata ogni giorno in quel punto preciso. Ora c’è un tombino. Uno scolo che porta al mare sotto terra. Un cunicolo sporco che monda con acqua che sa di terra. Là voglio immaginare che siano finite le lacrime, il sangue, la paura, quella Clara che non è mai più tornata.
Clara o la disillusione
**Tutti i diritti sono riservati. è vietata la riproduzione e la distribuzione, parziale o totale, di questo scritto**
Photo by Jason Leung on Unsplash
